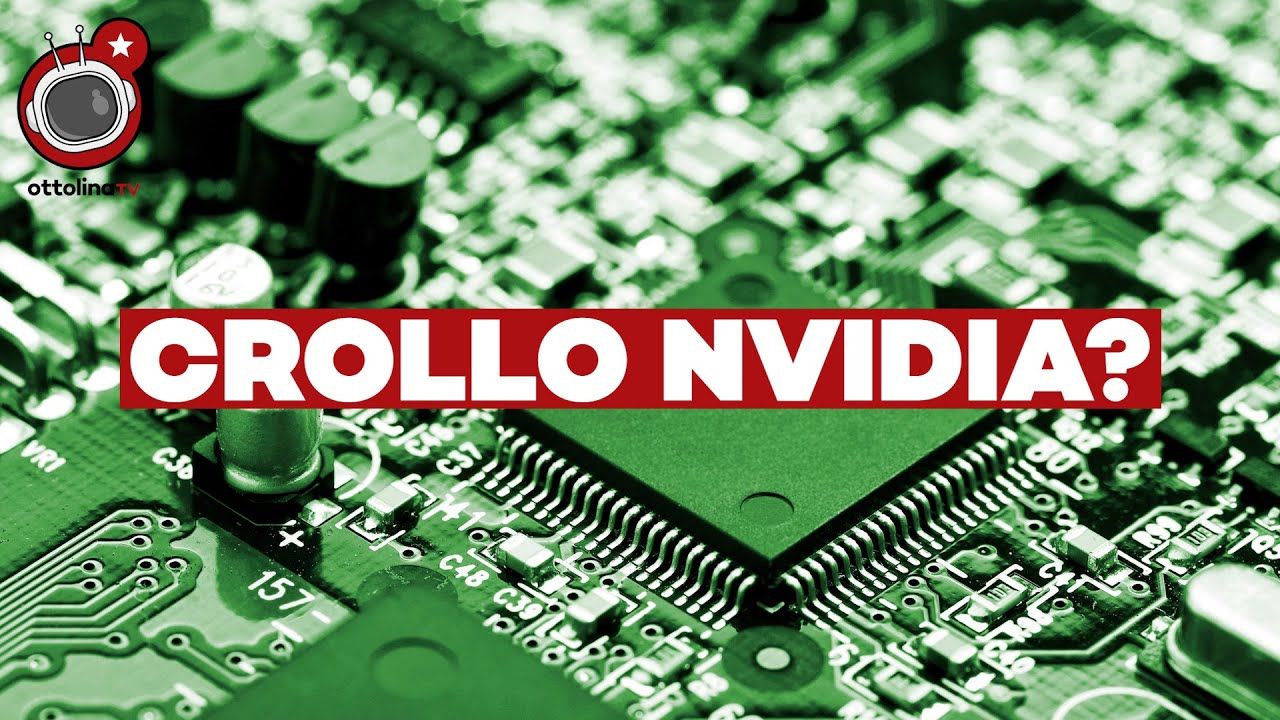Palestina nei BRICS – Come il Sud globale costruisce concretamente un mondo più democratico
Mentre il comandante in capo del mondo libero e democratico Genocide Joe approvava l’ennesimo pacchetto di forniture militari da 20 miliardi di dollari per permettere a Israele di continuare a sterminare pacificamente i bambini palestinesi, il plurimorto sanguinario dittatore del Cremlino optava per una strategia decisamente meno rispettosa dei diritti umani: invitava ufficialmente il Presidente dell’autorità palestinese Mahmoud Abbas a partecipare al prossimo summit dei BRICS che si terrà nella cittadina russa di Kazan il prossimo ottobre, un summit potenzialmente di portata storica: la Russia, infatti, che in quanto sporca e cattiva è giustamente sanzionata dai difensori del diritto internazionale e dei diritti umani a stelle e strisce, è forse in assoluto il Paese al mondo che sente con maggiore urgenza la necessità di emanciparsi dalla dittatura globale del dollaro e quindi, con ogni probabilità, approfitterà della sua presidenza di turno dei BRICS per provare in ogni modo ad accelerare il più possibile il complicatissimo ma rivoluzionario processo verso l’emancipazione dalla dittatura globale del dollaro, che rappresenta il vero pilastro fondamentale dell’imperialismo – e quindi di un sistema di relazioni internazionali ancora oggi intollerabilmente antidemocratico che ricorda molto da vicino il vecchio colonialismo. Insomma: anche a questo giro, mentre l’Occidente collettivo a guida USA si riempie la bocca di slogan vuoti su democrazia, diritto e progresso mentre commette ogni sorta di crimine possibile immaginabile, i Paesi del Sud globale – a partire proprio da quelli più sporchi e cattivi che tanto sdegno generano nei salotti buoni della sinistra progressista de noantri– al netto di tutte le contraddizioni lavorano concretamente giorno e notte alla costruzione di un mondo più pacifico e democratico. E voi, da che parte state?

La contrapposizione non potrebbe essere più chiara ed evidente: di fronte al primo genocidio della storia in diretta streaming, il mondo si divide nettamente in buoni e cattivi, con i buoni che però accolgono tra innumerevoli standing ovation i carnefici e i cattivi, invece, che si schierano dalla parte della resistenza. L’ufficializzazione dell’invito da parte di Mosca all’autorità palestinese a partecipare al prossimo Summit dei BRICS, che si terrà in ottobre nella prestigiosa capitale del Tartastan, rischia di creare l’ennesimo irrisolvibile cortocircuito cognitivo nella mente delle anime belle della sinistra progressista occidentale; i benpensanti dell’Occidente collettivo, infatti, fino ad oggi hanno sempre cercato disperatamente di giustificare il sostegno incondizionato dei loro Paesi e delle loro forze politiche di riferimento allo sterminio indiscriminato dei bambini palestinesi, trincerandosi dietro la formula dei due popoli, due Stati che, ancora oggi, viene indicata come l’unica soluzione possibile per soddisfare contemporaneamente due principi che ritengono (almeno a parole) inviolabili: il diritto di Israele a difendersi, da un lato, e il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e al rispetto dei diritti umani fondamentali. Purtroppo però – recita la formula giustificazionista più in voga – la costruzione dei due Stati è un processo incredibilmente complesso e, ovviamente, è reso ancora più complesso dagli opposti estremismi che la sinistra benpensante vuole sempre necessariamente vedere ovunque: c’è un regime di apartheid? No, macché: lo Stato democratico di Israele rispetta i diritti di tutti, solo che poi gli estremisti palestinesi ne approfittano per terrorizzare i giovani che vanno ai rave e ai pride e, dall’altra parte, alcuni estremisti israeliani, nell’esercitare il loro sacrosanto diritto all’autodifesa, si lasciano andare a qualche eccesso di troppo. E’ in corso un genocidio? Ma figurati! E’ solo che gli estremisti palestinesi usano la popolazione civile come scudi umani e, dall’altra parte, qualche estremista israeliano si fa un po’ troppo pochi scrupoli a massacrare una trentina di civili per colpire ogni presunto miliziano. Se già, invece di 30, fossero 25, ci si potrebbe stare.
D’altronde si sa, appunto: gli estremisti son da tutte le parti; l’importante però è che si continui ad affermare che l’obiettivo rimane quello di creare due Stati per due popoli anche se, nel frattempo, si continua ad armare e a sostenere economicamente una delle due parti in causa come se non ci fosse un domani. E continuare ad affermare che l’obiettivo è creare due Stati costa abbastanza poco; anzi, si può fare anche molto di più: si potrebbero anche proprio riconoscere davvero due Stati, tanto – alle condizioni attuali – anche se formalmente arrivi a riconoscerlo sul serio uno Stato palestinese, un vero Stato palestinese, in realtà non può esistere. Il punto è che affinché uno Stato possa esistere, non basta scriverlo su un foglio di carta: uno Stato esiste sul serio se e solo se ha gli strumenti concreti per esercitare una qualche forma di sovranità; non voglio dire esercitare piena sovranità in tutti gli ambiti di sua competenza perché, dopo 40 anni di globalizzazione neoliberista, questo significherebbe sostanzialmente dire che non possono esistere gli Stati tout court, ma almeno qualche forma sostanziale di sovranità sì. Ora, che forma di sovranità potrebbe mai esercitare uno Stato che si ritrovasse a governare la Palestina per come è stata ridotta? Il cibo dovrebbe comunque arrivare dall’esterno sotto forma di aiuti alimentari, l’acqua dovrebbe arrivare per gentile concessione degli israeliani, che negli anni si sono impossessati manu militari di ogni singola fonte di approvvigionamento; anche l’energia elettrica dovrebbe arrivare per gentile concessione degli israeliani e anche per la sicurezza una vera sovranità sarebbe palesemente impensabile, soprattutto in quello spezzatino privo di ogni continuità territoriale nel quale centinaia di insediamenti totalmente illegali da parte dei coloni sionisti hanno trasformato la Cisgiordania. Ciononostante, un pezzo consistente della politica dell’impero ritiene comunque troppo rischioso fare qualche passo avanti nel riconoscimento di uno Stato formalmente indipendente per i palestinesi e quindi, da decenni, lavora senza sosta per fare in modo che anche all’interno della Palestina stessa non vi siano le condizioni politiche minime necessarie per garantire in prospettiva una qualche forma di governo minimamente sostenibile.
Lo strumento è quello classico: divide et impera, dividere la popolazione tra fazioni politiche e riconoscerne una come interlocutore più o meno affidabile e l’altra come capro espiatorio di ogni male possibile immaginabile. La fazione individuata come interlocutore – che, nel caso specifico, è l’OLP di Mahmoud Abas – a questo punto viene sottoposta a un semplice ricatto: visto che sei totalmente dipendente da noi per qualsiasi cosa, per ricevere un po’ di elemosina devi soddisfare supinamente ogni nostra richiesta. Ovviamente, questa sottomissione totale ai voleri della forza occupante viene vista di cattivo occhio dal grosso della popolazione dal momento che, da che mondo è mondo, ai popoli – chissà poi perché – essere sottomessi alle occupazioni straniere gli sta leggerissimamente sui coglioni; questa cosa, ovviamente, non fa che alimentare la fazione di quelli che nel progetto di divide et impera dell’occupante sono finiti nel team cattivi. Allora nel contratto di ricatto stipulato col team buoni diventa sempre più grande la parte che prevede che gli interlocutori debbano consegnare agli occupanti la testa dei membri del team cattivi e così ovviamente, giustamente, il team buoni diventa sempre più minoritario e isolato all’interno della sua stessa popolazione, fino a che gli occupanti non hanno tutti gli elementi per sostenere (con qualche ragione) che la creazione dello Stato indipendente degli occupati non si può fare perché la fazione individuata come unico interlocutore possibile è troppo debole e non sarebbe in grado di governarlo. E per i progressisti da apericena e gli analfoliberali, a questo punto, il ragionamento non fa un piega: insomma, gli imperialisti e i coloni sono criminali, ma non sono mica scemi. Ora, l’invito da parte di quel perfido tiranno di Putin a partecipare al summit dei BRICS stravolge totalmente questo intero paradigma, soprattutto alla luce di quanto è stato fatto nei mesi precedenti nei confronti della Palestina in particolare proprio da Cina e Russia. L’ingresso dello Stato palestinese nel salotto buono del nuovo ordine multipolare, infatti, ha un obiettivo molto evidente: aiutare lo Stato palestinese a ottenere gli strumenti concreti che gli garantiscano in prospettiva di esercitare, almeno da alcuni punti di vista, proprio quella sovranità che la pantomima dell’imperialismo occidentale vuole negare alla radice; d’altronde, i BRICS e le altre istituzioni del nuovo ordine multipolare sono nate tendenzialmente proprio per questo.
L’imperialismo – e, in particolare, quello che definiamo spesso il superimperialismo (e cioè l’imperialismo nella forma specifica che ha assunto nell’era della globalizzazione neoliberista) – può essere definito come quel sistema mondo che aspira a minare alla radice la capacità di tutti gli Stati di esercitare la loro sovranità tranne che per lo Stato del centro imperiale (e, cioè, gli USA) e questa è esattamente la condizione che hanno accettato passivamente tutti gli Stati che oggi definiamo liberi e democratici: la cessione della loro sovranità alle oligarchie finanziarie e alla macchina bellica del centro imperiale. Per emanciparsi da questa condizione di sottomissione strutturale, però, a un certo punto i Paesi del Sud globale si sono cominciati a dotare di istituzioni multilaterali che, in mezzo a mille contraddizioni, potessero permettergli di provare a tornare a conquistare un po’ di sovranità; e di queste istituzioni multilaterali, i BRICS sono probabilmente la più importante in assoluto, soprattutto dal momento che è proprio in questa sede che si dovrebbe discutere il singolo aspetto che – probabilmente più di ogni altro – negli ultimi 40 anni ha limitato la sovranità dei singoli Stati, e cioè la dittatura del dollaro.
L’emancipazione dal dollaro come valuta di riserva globale è una sfida titanica: in 5 secoli di vita, il capitalismo globale ha sempre avuto una valuta di riserva di ultima istanza che veniva utilizzata per il grosso delle transazioni commerciali internazionali e questa valuta è sempre stata la valuta emessa dal Paese che, in quella fase storica, stava in cima alla gerarchia dei Paesi capitalistici: la potenza egemone, come è stato l’impero britannico per buona parte del XIX secolo e quello a stelle e strisce per buona parte del XX fino ad oggi. Il fatto è che al sistema, per come ha funzionato fino ad oggi, per gli scambi internazionali serve una moneta stabile e sicura, universalmente accettata da tutti e che possa circolare liberamente attraverso i confini (in particolare, attraverso i confini del Paese che la emette), ma permettere ai capitali di fluire liberamente attraverso i propri confini significa, in soldoni, rinunciare agli strumenti di controllo del flusso dei capitali che sono indispensabili per rendere efficaci le politiche economiche scelte dal governo e questo, a sua volta, significa solo due cose: o che rinunci anche tu ad esercitare una parte fondamentale della tua sovranità, oppure che di default la tua politica economica coincide perfettamente con gli interessi dei detentori del grosso di quei capitali che attraversano i tuoi confini; e questa condizione è soddisfatta solo ed esclusivamente dalla potenza egemone. Emanciparsi dalla dittatura del dollaro quindi, stando così le cose, significherebbe necessariamente trovare un degno sostituto e, quindi, anche riconoscere a un’altra potenza – che non potrebbe (per ovvie ragioni) che essere la Cina – lo status di nuova potenza egemone del capitalismo globale, ma a quel punto si sarebbe di nuovo punto e a capo perché i problemi che derivano dall’avere una superpotenza che gerarchicamente sta sopra a tutti gli altri, limitandone considerevolmente la sovranità, si ripresenterebbero più o meno uguali spiaccicati, solo con un altro nome. Fortunatamente, però, questo rischio non sembra tutto sommato molto realistico: la totale simbiosi che si è verificata nei precedenti imperi tra detentori del capitale e macchina statale, infatti, nella Repubblica Popolare cinese che – piaccia o non piaccia – continua ad essere uno Stato socialista (eccome), molto semplicemente non c’è, proprio manco lontanamente; e lo Stato cinese non ha nessunissima intenzione di rinunciare al controllo del flusso dei capitali che le garantisce di potersi dare obiettivi di politica economica che non coincidono con gli interessi particolari di chi detiene il capitale. Per superare la dittatura del dollaro, allora, l’unica possibilità è superare tout court l’idea stessa dell’esistenza di una valuta di riserva di ultima istanza, il che – in soldoni – equivale a dire che l’unica possibilità è superare l’imperialismo in quanto tale e, cioè, la forma specifica che si è data il capitalismo per tentare di superare le sue contraddizioni intrinseche pur di continuare a garantire il dominio dell’1% sul resto della popolazione; insomma: non esattamente un giochetto da ragazzi.
L’ultima volta che qualcuno c’aveva provato era il 1944, quando a Bretton Woods John Maynard Keynes aveva cercato di approfittare di un momento politico contingente particolarmente favorevole – dove le storture intrinseche dell’imperialismo, dopo l’ascesa del nazifascismo e due guerre mondiali, erano evidenti anche alle capre di montagna – per proporre un’architettura finanziaria globale rivoluzionaria che al posto di una valuta di riserva di ultima istanza, prevedeva l’istituzione di uno strumento monetario ad hoc chiamato Bancor che sarebbe dovuto servire per regolare le transazioni internazionali e che avrebbe dovuto permettere di intervenire per correggere le asimmetrie nelle bilance commerciali dei vari Paesi ed evitare così il riemergere delle tensioni strutturali che avevano portato al disastro dei decenni precedenti. I BRICS oggi, sostanzialmente, stanno lavorando proprio in quella direzione e, per quanto la gestazione sia troppo lunga e tortuosa per i tempi dettati dall’era dell’iper-informazione, stanno facendo importanti passi avanti: il primo step consiste nel favorire gli scambi bilaterali tra i diversi Paesi nelle valute locali e qui, a mostrare la strada, sono indubbiamente Cina e Russia. E il bello è che sono proprio gli USA stessi ad aver accelerato in maniera esponenziale il processo: come conseguenza della guerra per procura degli USA in Ucraina e della montagna di sanzioni anti-russe che l’hanno accompagnata sin dagli esordi, nel 2023 l’interscambio commerciale tra i due Paesi leader del nuovo ordine multipolare è cresciuto di circa il 25% e per il 90% è avvenuto in rubli e yuan. Anche una bella fetta dell’interscambio tra Russia e India ormai avviene nelle rispettive valute e nel 2024, per la prima volta, la maggioranza dei pagamenti internazionali che hanno coinvolto la Cina sono avvenuti in yuan invece che in dollari; e calcolando che la Cina è di gran lunga la prima potenza commerciale al mondo e l’unica vera grande superpotenza manifatturiera del pianeta, non è proprio pochissimo. Anche il commercio internazionale del petrolio, che fino al 2022 avveniva in dollari per poco meno del 100%, nel 2023 è avvenuto per almeno un quarto del suo valore complessivo in valute locali. Ovviamente tutto questo è ben lontano da mettere in discussione il predominio del dollaro, soprattutto dal momento che le transazioni commerciali internazionali rappresentano soltanto una piccola frazione dei movimenti valutari globali che, ovviamente, per la stragrande maggioranza dei volumi hanno a che vedere con transazioni di carattere meramente finanziario, totalmente scollegate dall’economia reale; ciononostante, la fine della dittatura del dollaro potrebbe essere più vicina di quanto si possa pensare perché – come a ogni dittatura – per stare in piedi anche a quella del dollaro non basta essere semplicemente maggioranza: deve essere totalizzante, come dimostrano plasticamente i fallimenti che lo strumento delle sanzioni unilaterali sta accumulando uno dietro l’altro. Affinché le sanzioni funzionino, infatti, non è necessario che le alternative al dollaro siano chissà quante e chissà quanto diffuse: basta che ci siano delle alternative, anche marginali; ora quindi si tratta – mentre, da un lato, si continua ad allargare il ricorso all’utilizzo delle valute locali per le transazioni bilaterali – di cominciare a ragionare su un’architettura più complessiva (sulla falsariga di quella proposta da Keynes a Bretton Woods) che permetta di regolare le transazioni internazionali di tutti quei Paesi del Sud globale – ma non solo – che si sono stufati di pagare dazio all’egemonia USA.
Uno degli ostacoli principali fino ad oggi è stato rappresentato proprio dall’India, che se da un lato persegue una sua agenda nazionale incompatibile con il dominio incontrastato del superimperialismo finanziario USA, dall’altro teme di favorire troppo l’ascesa della Cina; ed ecco così che quando nel 2023, al summit di Johannesburg, il tema dell’utilizzo delle valute locali per l’interscambio tra i BRICS era stato posto sul tavolo, l’India si era dichiarata non favorevole, ma – a quanto pare – le cose sono cambiate. E’ quanto rivela la pagina economica di The Hindu in vista del vertice di Kazan: L’India potrebbe prendere in considerazione la proposta di utilizzare le valute nazionali titola, anche se a condizione però, continua il titolo, che non sia vincolante; “Nuova Delhi”, avrebbe dichiarato a The Hindu una fonte governativa di primo livello che avrebbe voluto però mantenere l’anonimato, “sta esaminando una risposta adeguata in base alla misura in cui trarrebbe beneficio economicamente e diplomaticamente dalle proposte senza aumentare le sue vulnerabilità nei confronti della Cina”. Il compromesso, avrebbe affermato la fonte anonima, consisterebbe nel fatto che “All’interno dei BRICS anche se sei d’accordo per il regolamento valutario, puoi comunque scegliere di non applicarlo con alcuni Paesi, mentre lo applichi con altri. Se l’India sceglie di non trattare con la Cina in yuan e rupie, va bene. Ma potrebbe riguardare altri Paesi, ad esempio il rublo o il rand”; “Il regolamento valutario all’interno del blocco BRICS” commenta l’articolo “darà ai membri la flessibilità di utilizzare una particolare valuta accumulata in un Paese per commerciare con un altro. Ad esempio, la Russia potrebbe spedire la rupia in eccedenza raccolta nei suoi conti in India e convertirla in pesos brasiliani per pagare il Brasile per alcune transazioni. Oppure in rand sudafricani per effettuare pagamenti in Sudafrica”.
Ovviamente, da qui alla creazione della famigerata valuta dei BRICS ce ne corre, ma l’idea sostanzialmente è che una volta rodato questo meccanismo si possa dare vita – appunto – a una valuta fittizia simile al Bancor di Keynes con la quale regolare l’interscambio commerciale e il cui valore è determinato da un paniere contenente tutte le valute dei Paesi coinvolti. Insomma: al di là della propaganda, i BRICS continuano a lavorare per restituire concretamente spazi di sovranità ai diversi Paesi e, invece della strategia del divide et impera, lavorano per la riconciliazione e il dialogo, anche sul fronte interno, anche se costa una fatica enorme e una pazienza certosina; già in marzo Putin aveva organizzato un importante incontro con le varie fazioni palestinesi – dall’OLP ad Hamas, passando per la Jihad Islamica Palestinese e il Fronte Popolare di Liberazione – nel tentativo di promuovere un governo di unità nazionale. Dopo aver ottenuto una dichiarazione congiunta, il dialogo era completamente naufragato a causa dell’ennesimo infame atto di tradimento da parte dell’OLP di Abu Mazen. Ma la storia si fa con quel che c’è, non quello che ci piacerebbe ci fosse, ed ecco così che grazie anche ai veri e propri deliri delle fazioni più dichiaratamente razziste e fascistoidi del governo israeliano – che sono riuscite a far passare alla Knesset una risoluzione che rifiuta categoricamente ogni ipotesi di Stato palestinese, minando così alla radice il ruolo dell’OLP di interlocutore e, quindi, costringendolo a venire a più miti consigli – a luglio a riprovarci è stata la Cina, che ha portato a casa la ratifica da parte di 14 fazioni palestinesi di un accordo che prevede l’istituzione “di un governo di unità nazionale che gestisca gli affari del popolo palestinese sia a Gaza che in Cisgiordania, supervisioni la ricostruzione e prepari le condizioni per le elezioni”.
Che strano mondo che è un mondo dove i buoni firmano i missili diretti contro i bambini e ci scrivono sopra Uccidili tutti e i cattivi sono l’unica speranza che i diseredati della terra hanno per un futuro un po’ più pacifico e democratico… Contro il mondo al contrario della propaganda di fine impero, abbiamo bisogno come il pane di un vero e proprio media che dia voce agli interessi e ai diritti del 99%; aiutaci a costruirlo: aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina Tv su GoFundMe e su PayPal.
E chi non aderisce è Massimo Gramellini