ANDREA ZHOK e la critica del nichilismo liberale
Nessuno può permettersi di non dichiararsi liberale: è questa la prima regola del fight club che è diventato il dibattito pubblico; la seconda: Nessuno deve chiedersi liberale cosa significa sul serio.
Ci ha provato Andrea Zhok in Critica della ragione liberale. Una filosofia della storia corrente; il termine liberale, infatti, è diventato molto banalmente sinonimo di tutto ciò che è tolleranza, apertura e civiltà: l’esatto contrario di populismo che, invece, sarebbe sinonimo di tutto ciò che è intolleranza, ottusità e dominio incontrastato degli istinti più bassi. Non esattamente un utilizzo rigorosissimo del linguaggio, diciamo. Per ridare un senso alle parole Zhok, allora, cerca di andare oltre la propaganda e fa uno sforzo titanico per ricostruire la genesi storica del liberalismo: come sarebbe effettivamente emerso e da quali processi. Buona visione.

Quando parliamo di liberalismo politico parliamo, scrive Zhok, di un “orientamento politico magmatico, privo di una forma precisa, definito di volta in volta da ciò contro cui combatte, il cui minimo comune denominatore ideologico è in ultima istanza solo una concezione della libertà negativa, individuale ed economica. La particolarità di questa concezione della libertà è la sua neutralità assiologica: non è libertà per fare alcunché, ma libertà da interferenze altrui”. (p.151) Possibile che un sistema di pensiero così minimalista abbia avuto tanto successo? Quali sono i fattori che lo innervano e che, uniti, hanno dato forza a una proposta politica tanto misera e superficiale? Zhok individua la genesi della ragione liberale come un processo prodotto dalla convergenza di quattro ingredienti essenziali nati nel mondo antico e premoderno, e cioè la libertà individuale, il denaro, la tecnoscienza e lo Stato: “È la convergenza di questi quattro momenti, ciascuno a suo modo capace di incrementare le forze sociali e produttive disponibili” scrive l’autore “a caratterizzare lo sviluppo socioeconomico del mondo occidentale negli ultimi due secoli, per poi estendersi nella seconda metà del XX secolo a gran parte del resto del pianeta”.
Partiamo dalla libertà individuale: la sua genesi è fatta risalire dall’autore alla svolta storica prodotta dell’invenzione della scrittura alfabetica nella Grecia antica; senza la scrittura alfabetica infatti, sostiene l’autore, è sostanzialmente impossibile pensare all’individuo, e cioè a un soggetto che riflette su di sé e sul mondo circostante e che è capace di pensarsi – proprio come faceva Socrate – come qualcosa di distinto dalla comunità di riferimento. L’individualismo moderno, che caratterizza la società occidentale e contemporanea, è figlio di questa svolta storica che ha subìto un’accelerazione a partire dall’invenzione della stampa a caratteri mobili e, in seguito, dell’informatica: la libertà individuale sarà intesa nel liberalismo come libertà negativa e cioè, sostanzialmente, mancanza di impedimenti; l’individuo si libera dai legami comunitari e solidali. Non è più partecipazione, come per gli antichi, ma isolamento egoistico, la libertà di farsi gli affari propri; svincolato da valori comuni, l’individuo deve semplicemente calcolare vantaggi e svantaggi economici del proprio agire all’interno di una società di mercato. L’avvento della tecnoscienza, invece, è quello che rende possibile la rivoluzione industriale, ma che rivoluziona completamente anche il nostro modo di pensare la natura stessa: con la tecnoscienza, infatti, la natura diventa un semplice aggregato misurabile di cose che servono a far quattrini e il sapere scientifico è tanto più importante quanto più permette di dominare il mondo naturale e umano. E qui veniamo alla terza componente, che è il denaro perché, per rendere tutto misurabile, serve un’unità di misura universale: il denaro consente di facilitare gli scambi, misurare e accumulare valore ed è in grado di esercitare il suo potere a prescindere dalla sua genesi sociale; quello del denaro è un potere asociale e ademocratico. Il denaro, come ricchezza liquida, estende sempre più il proprio potere – diventando pervasivo – dall’Ottocento, in una società sempre più urbanizzata e monetizzata; in un mondo senza alcun valore obiettivo tutto diventa prezzabile, quindi acquistabile attraverso il denaro. Per finire c’è lo Stato, posto a garanzia dell’ordine tramite esercito, polizia e sistema giuridico; lo Stato liberale è svuotato da progetti politici che facciano capo a decisioni valoriali: non è altro che gendarme degli interessi dell’élite. Lo Stato deve soltanto favorire il mercato e i suoi attori: il politico, nel liberalismo, è ridotto al tecnico; il governo degli uomini che, normalmente, richiederebbe la costruzione di valori condivisi e scelte legittimate da cittadini, diventa così sovrapponibile all’amministrazione delle cose.
Finché questi quattro ingredienti sono rimasti separati, però, non accadde alcuna rivoluzione; solo dalla loro miscela esplosiva nell’Inghilterra del Settecento scoppiò la rivoluzione permanente, tuttora in corso: “Sarà nella cornice statale inglese, tra Seicento e Settecento” scrive Zhok “che l’individualismo etico della riforma protestante, una matura circolazione monetaria, e i successi della razionalità tecnoscientifica convergeranno sinergicamente, portando alla luce per la prima volta la ragione liberale e il suo correlato operativo, l’economia capitalistica”. Senza l’imporsi del capitalismo come sistema di produzione, la ragione liberale sarebbe rimasta una ideologia tra le altre; come sintetizza Zhok: “Del successo storico della ragione liberale è stata poi parte essenziale la sua istituzionalizzazione in forma capitalistica, con la creazione della scienza economica e con l’asservimento della natura (e degli uomini) alle finalità del “sistema economico”. (p.85)
Questo modello, infine, raggiungerà un suo compimento nel neoliberismo, l’imporsi del quale – alla fine degli anni settanta del Novecento – venne salutato da Fukuyama come, letteralmente, la fine della storia. Contro questa lettura trionfalistica, Zhok mette in risalto le crisi e degenerazioni che questa supposta vittoria comporta: dalla frammentazione dell’identità personale a quella dell’identità collettiva, allo sviluppo sempre più accelerato di tecnologie prive di controllo sociale, all’inquinamento ambientale; il sistema liberale finisce col minare i suoi stessi presupposti sociali, cercando di rattoppare queste contraddizioni con palliativi come il consumismo, la diffusione di droghe e psicofarmaci, l’industria dell’intrattenimento e dello svago, la pervasività del diritto che norma ogni aspetto della vita. E quando queste “toppe”, questi palliativi, non bastano più, il liberalismo risponde con l’opzione autoritaria degli stati d’eccezione; si compie, in questo modo, quella che potremmo chiamare la trappola di Hobbes: la conseguenza logica della ragione e della società liberale è la guerra di tutti contro tutti, che ha come conseguenza la necessità del Leviatano, di un potere totalitario in grado di portare ordine là dove c’è guerra e autodistruzione.
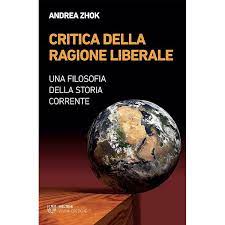
Cosa possiamo fare dunque? L’autore stesso ci lancia un salvagente, ricordandoci che “Nella storia le determinazioni non sono mai cause necessitanti […] ma circoscrivono spazi di maggiore o minore possibilità”. (p. 14) Questo significa che abbiamo sempre la possibilità, per quanto ristretta, di agire per modificare la realtà storica attuale, sottraendoci al dilemma che vede come conclusioni necessarie l’autodistruzione sociale o una sua torsione totalitaria. Per chi vuole riflettere insieme a noi su come farlo concretamente, l’appuntamento è per mercoledì 24 gennaio alle 21.00 in diretta su Ottolina Tv con una nuova puntata di Ottosofia, il format di divulgazione storica e filosofica di Ottolina Tv in collaborazione con Gazzetta filosofica: ospite d’onore Andrea Zhok, professore di Antropologia filosofica e Filosofia morale presso l’Università degli Studi di Milano e autore di Critica della ragione liberale. Una filosofia della storia corrente (Meltemi, 2020).
E se nel frattempo anche tu credi che per una democrazia sostanziale occorra combattere il liberismo reale, aiutaci a costruire il primo vero e proprio media che dà voce agli interessi concreti del 99%: aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina Tv su GoFundMe e su PayPal.
E chi non aderisce è Michele Boldrin






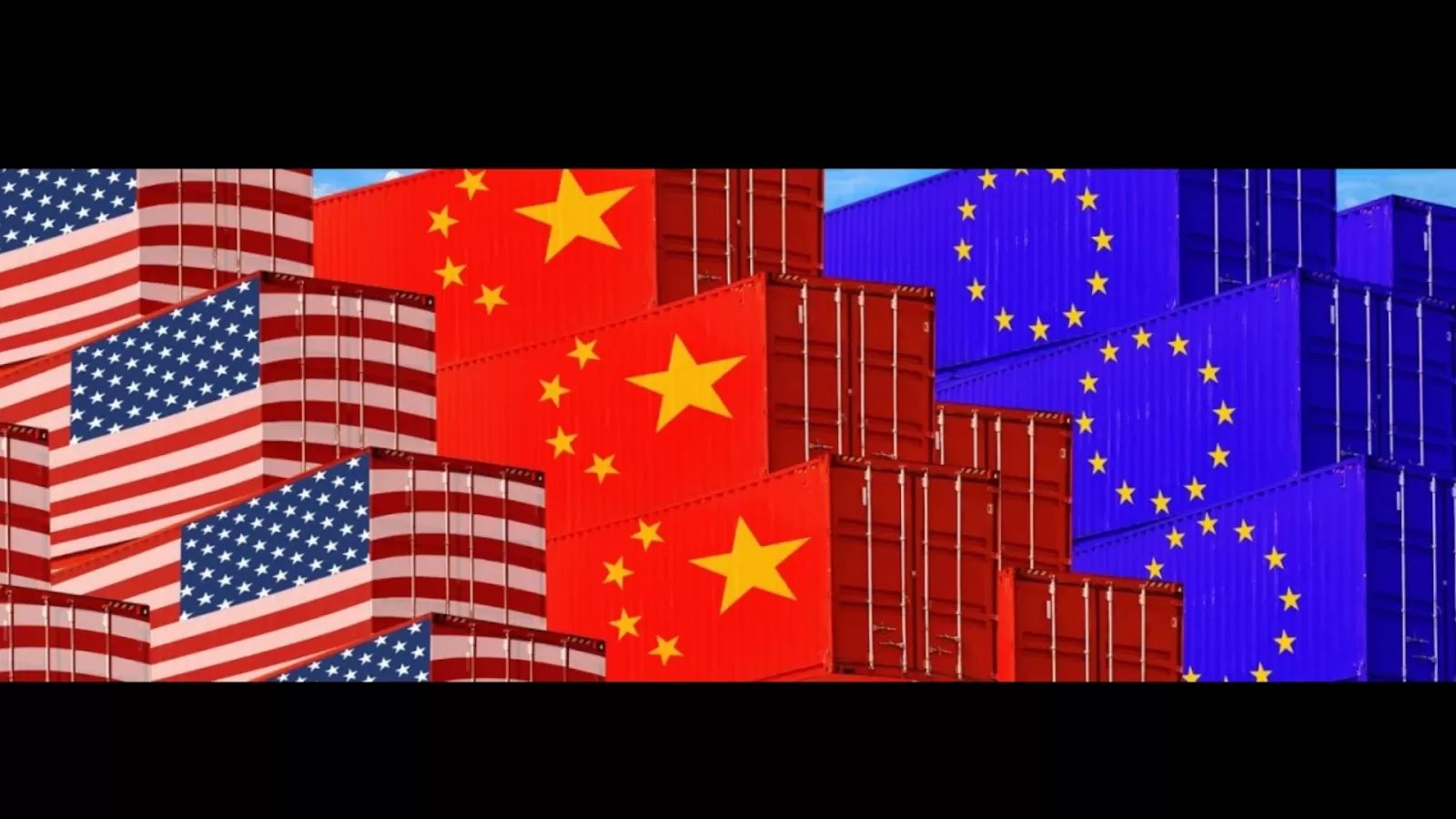





Oh finalmente!
Un posto in cui ascoltare il professor zhok scisso dagli estremisti cattolici ke impestano il suo canale telegram!
Nn fossi disoccupato vi finanzierei!
Grz!